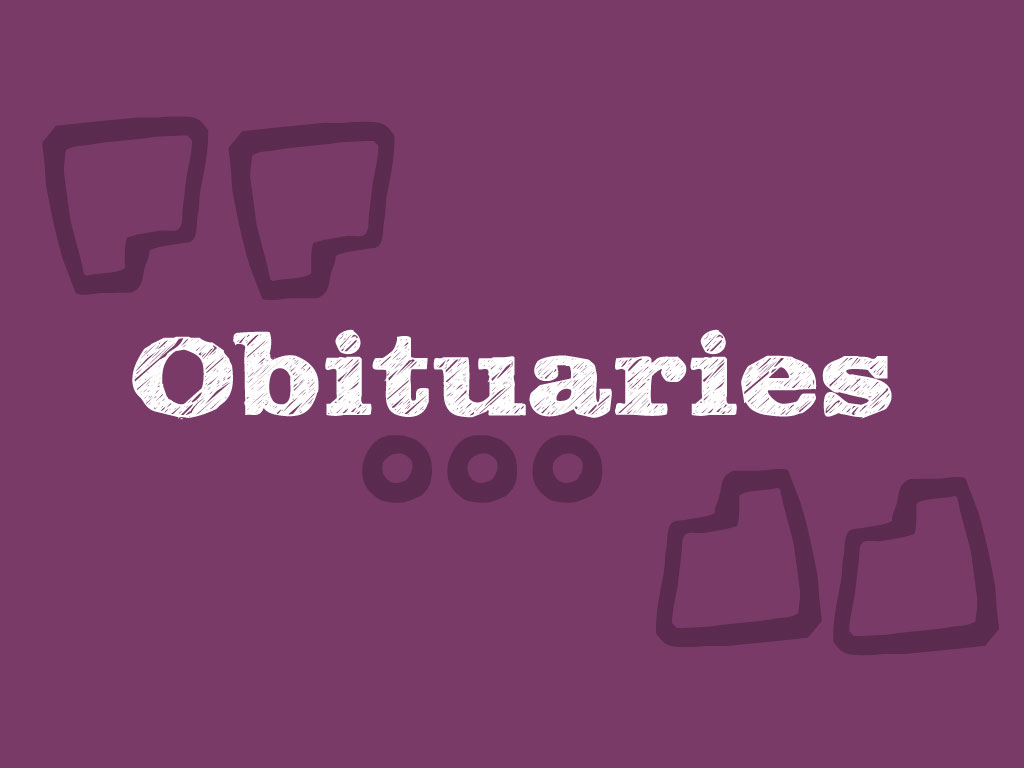Matita vagante, per Sergio, con Sergio
di Sergio Mattarella
Quello che segue è l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’incontro con una rappresentanza del corpo della polizia penitenziaria nel 207 anniversario della sua costituzione. In quell’occasione il presidente manifesta la sua preoccupazione per il numero abnorme di detenuti suicidi: “Le istituzioni non si sentano estranee a quel mondo”. Riprendiamo l’intervento con lo spirito di dialogo che fu di Marco Pannella: preoccuparsi, vale arsi, vale a dire: “occuparsi”.
Benvenute e benvenuti al Quirinale. È davvero un piacere incontrarvi per farvi gli auguri per i 207 anni di vita del Corpo di Polizia penitenziaria. Ne ho parlato poc’anzi nel colloquio con il Capo Dipartimento. Abbiamo parlato dei vari problemi, delle esigenze, e lo ringrazio per l’esposizione così puntuale che ha fatto.
Avete un compito di grande rilievo, caratterizzato da aspetti di grande delicatezza. Vi sono vari profili, contrassegno del vostro impegno: da quello dell’indispensabile sicurezza a quello finalizzato alla rieducazione per il possibile reinserimento nella vita sociale dei detenuti. In quest’ambito si svolge il vostro impegno, tra questi due pilastri dell’attività.
Pochi giorni fa abbiamo avuto al Quirinale due giovani detenuti – due minori – che hanno fatto uno stage di alcuni giorni nella nostra cucina, accompagnati da vostri colleghi. Altre volte ho incontrato qui, o altrove, dei detenuti, accompagnati da vostri colleghi, giovani e meno giovani, per vedere esposta la loro attività e incoraggiarli. Sono piccoli gesti simbolici, ma che vogliono essere, in realtà, dei messaggi perché tutte le istituzioni, a qualunque livello, e tutti i corpi sociali, si sentano non estranei al mondo penitenziario, ma chiamati a fornire collaborazione per quanto avviene dentro il mondo degli istituti penitenziari.
Il vostro impegno in quest’ambito, su due pilastri – ripeto: sicurezza e rieducazione – so che viene assolto con dedizione. So bene, anche, con grandi sacrifici, con professionalità. Come poc’anzi ricordava il Capo Dipartimento, professionalità crescente, costantemente aggiornata.
Elemento fondamentale – questo della professionalità – che comporta un’esigenza di controllo di tutto, anche di sé stessi, naturalmente, e che richiede un rispetto dei confini della professionalità, del comportamento professionale. Questo è importante, e voi lo sapete meglio di chiunque altro, assai meglio di me. Perché la vostra autorevolezza, la vostra autorità, necessaria negli istituti, è esaltata dalla professionalità piena e autentica, dal muoversi dentro questi confini di professionalità.
Questo, naturalmente, ha un grande pregio, particolarmente per le grandi difficoltà che contrassegnano l’ambiente in cui operate. Condizioni particolari, piene, appunto, di difficoltà. Richiede un sovrappiù di professionalità, ed io vi ringrazio per il lavoro che spiegate e per l’impegno che viene manifestato dall’amministrazione di svilupparla il più possibile, costantemente.
Conosco, naturalmente, altri ostacoli che gravano sul vostro compito e le vostre attività. Ostacoli che richiamano il compito di altre istituzioni. Dal sovraffollamento carcerario, che rende difficile il vostro lavoro, molto più di quanto non dovrebbe essere, alle carenze di organico che pesano certamente, sovraffaticando il compito di ciascuno di voi, a quello che, in questo momento, è forse un elemento prioritario: l’esigenza di assistenza sanitaria dentro gli istituti penitenziari. È un’esigenza diffusa, ampia, indispensabile; la mancanza della quale fa sì che su di voi ricadano esigenze, sollecitazioni, richieste che non rientrano nei vostri compiti e nelle vostre funzioni.
Per questo è indispensabile che si affronti sollecitamente questo aspetto di un’efficace assistenza sanitaria dentro gli istituti penitenziari. Tutti questi aspetti richiedono interventi urgenti: completamento di organici, risposte al sovraffollamento carcerario e – ripeto – sopra ogni cosa, assistenza sanitaria.
Il numero dei suicidi nelle carceri dimostra quanto sia importante e indispensabile affrontarlo immediatamente, con urgenza. Tutto questo va fatto per rispetto dei valori della nostra Costituzione, che poc’anzi il Capo Dipartimento evocava e ricordava; per rispetto del vostro lavoro; per rispetto della storia del Corpo di Polizia penitenziaria e dei suoi caduti: vittime del terrorismo, della criminalità, e che ricordiamo con commozione. Anche per rispetto del loro sacrificio vanno assunti, dalle istituzioni, i provvedimenti necessari e le iniziative indispensabili, per rispetto della dignità di chi, negli istituti carcerari, lavora, e di chi vi è detenuto. Grazie per quanto fate e auguri per il vostro lavoro.
di Luciana Littizzetto
Quella che segue è la “lettera aperta” al ministro della Giustizia Carlo Nordio, scritta e letta da Luciana Littizzetto nel corso della puntata di “Che tempo che fa” del 17 marzo scorso. All’epoca i detenuti suicidi erano già 26.
Caro Nordio (Nordio come il Polo Nordio); caro Carlo,
fratello d’Italia, devoto ministro della Repubblica Italiana, uomo di spessore, bel tocco di toga, né rossa né nera, diciamo toga mélange. Tu che siedi dietro una scrivania che è riuscita a passare da Togliatti a Bonafede senza cadere in depressione. Tu che devi dividerti tra Meloni e Salvini, fra la Presidenta de Noartri e il barbaro col mojito, hai tutta la mia solidarietà umana.
Tu, che ho letto nel sito ufficiale del ministero della Giustizia, hai due gatti rossi: Rufus e Romeo Leonetto, come posso voler male a un uomo che chiama un gatto Romeo Leonetto? E quindi con tutta la delicatezza che posso, questa sera vorrei parlarti di carcere. Il tema più impopolare che ci sia in questo paese. Se ti proponessi, ministro, facciamo un bel dibattito sull’uso delle nacchere nella musica calabrese, riempiremmo i palasport; e invece, solo a sentire la parola carcere il cervello della gente si affloscia.
Questa settimana, purtroppo, un altro ragazzo si è tolto la vita: sono già 26 i suicidi nei primi 72 giorni di questo 2024, uno ogni tre giorni, dati più alti di sempre. Ma in carcere non muoiono soltanto i detenuti, ma anche i dipendenti del corpo di polizia penitenziaria. Dall’inizio dell’anno sono tre. Perché non si muore solo in carcere, si muore anche di carcere. Ma di questo pare che non gliene freghi una beata toga a nessuno.
Caro Nordio, ti scrivo perché sento che questa è una vera e propria crisi umanitaria. Non ho una soluzione, ma so che qualcosa si può e si deve fare. In carcere ci vanno i cattivi, quelli che hanno sbagliato, quelli che hanno fatto del male e che devono pagare per fare giustizia alle vittime della loro prepotenza e della loro violenza. Giusto così. Tutti noi vogliamo tornare a casa tranquilli e non vivere come dentro i Guerrieri della notte. Però non basta stipare le mele marce e poi dimenticarsene. Ce ne siamo già dimenticati prima, di loro, e forse per questo sono finiti così. Un detenuto è un problema di tutta la società, non solo di quelli che in carcere ci lavorano. E non mi dica che sono una buonista. Al contrario sono egoista, perché un ambiente carcerario senza dignità, affollato, con 10mila detenuti in più rispetto ai posti letto, con direttori che cambiano di continuo, con una carenza di personale qualificato, senza prospettive, senza possibilità di reinserimento, non crea più sicurezza, anzi crea più insicurezza per tutti.
Chiediamo ai detenuti di cambiare, ma cosa abbiamo fatto noi in questi anni per cambiare il sistema carcerario? Vogliamo riabilitare le persone e poi non muoviamo un dito. Siamo degli ipocriti. Bisogna metterli dentro e buttare la chiave, sento dire da ministri del governo. A parte che, se butti la chiave poi la tua riunione di famiglia come la fai?
Ma poi la prigione non è un pozzo dove buttare le chiavi. Al contrario, è un posto dove costruire chiavi per permettere a quante più persone possibili di uscire e trovare altre strade. L’articolo 27 della nostra Costituzione dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Se rinunciamo alla speranza che le persone possano cambiare, rinunciamo al futuro e questo è molto triste. Ho letto che la recidiva di quelli usciti dal carcere è quasi del 70%, il che dimostra quanto sia inutile il nostro attuale sistema. Chi esce di galera prima o poi finisce per tornarci. Ma il tasso di recidiva crolla al 2% per chi in carcere ha imparato un lavoro. Se la prigione ti offre una possibilità di cambiare, quindi, sei salvo. Lavoro, Nordio, non abbandono, ozio, annientamento e morte. Se n’era già accorto bene don Gallo molti decenni fa, lui che di carcerati ne frequentava tanti. Sarebbe stato bello vedere la fiction su di lui, peccato che la Rai l’abbia cancellata.
Ti saluto Nordio e scusa se ti do del tu, ma vorrei sentirti più vicino, so che ti trovi davanti un compito immane. Rendere moderne e umane le nostre carceri. Aiutaci a ricordare che chi va in galera ha sbagliato, ma non è sbagliato, come dice don Gino Rigoldi: possiamo sempre ricominciare. Se siamo vivi, aggiungo io. Con immutata stima, sempre tua, incensurata Lucianina.
di don Ettore Cannavera
Capire cosa sia davvero il carcere e che tipo di esperienza possa essere per coloro che la vivono in prima persona non è facile se non lo si sperimenta sulla propria persona. Nessuno si chiede che sorte avrà chi finisce in carcere, quanto sarà formativa o traumatica la sua esperienza carceraria e quale insegnamento potrà trarne per il suo futuro da persona libera. Ancora di meno ci si chiede che percorso di vita abbia alle spalle la persona che ha commesso quel crimine e quale sarebbe davvero la soluzione più giusta per lui. Perché prestare ascolto a chi ha sbagliato quando è così semplice affidare al carcere il compito di impartirgli una “giusta” lezione?
Il problema sta però nelle conseguenze di questa facile scelta. Il carcere, infatti, fallisce l’alto compito che gli assegna la Costituzione che sarebbe quello della rieducazione del reo ma sembra, invece, alimentare a sua volta illegalità, violenza e insicurezza come dimostra la percentuale altissima di persona che vi fa ritorno dopo aver compiuto nuovi reati. Con tutta la sua asprezza e il costo elevatissimo del suo mantenimento, il carcere non riesce dunque a respingere definitivamente fuori dai suoi cancelli chi abbia la sventura di averlo conosciuto. C’è poi un altro aspetto che rende il carcere, per com’è congegnato, uno strumento anticostituzionale: il numero inaccettabilmente alto dei suicidi che si registrano ogni anno. Ciò accade perché tra le sue mura si soffre, si soffre intollerabilmente. Ci vantiamo di aver abolito la pena di morte e poi distogliamo lo sguardo dal gesto dei ragazzi che troppo spesso quella pena si autoinfliggono, togliendosi la vita in cella. Tutto questo è inaccettabile.
Non solo perché la nostra Costituzione espressamente vieta che il detenuto soffra ma perché non esistono vite di scarto, non c’è esistenza che meriti di andar perduta, come ci insegna il Vangelo e le leggi della convivenza umana, che difendono senza eccezioni il diritto di ogni uomo a conservare la propria vita e la propria dignità.
Chiedo sempre più spesso, a politici e liberi cittadini che invocano più carcere e più severità, di dare più attenta lettura dell’articolo 27 della Costituzione. Si noterà che né la parola carcere, né alcun suo sinonimo, figura in nessun modo, mentre a lettere chiarissime si afferma che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità ma devono tendere alla rieducazione del condannato.
La pratica di affidare al carcere che ha sbagliato è un’idea recente nella storia dell’uomo e l’unica certezza che a oggi abbiamo è che essa non riesca a raggiungere il suo unico e vero scopo: garantire la sicurezza della società e tendere alla rieducazione del condannato.
Il punto di vista di chi scrive è quello di un ex cappellano di un carcere minorile in Sardegna, che ha deciso di vivere all’interno del carcere per un anno intero allo scopo di capire la realtà dei ragazzi che vi erano rinchiusi. Solo condividendo le giornate coi giovani detenuti avrei potuto conoscerne davvero la realtà e le storie, capire cosa il carcere insegnasse loro. Il mio giudizio sulla realtà della detenzione si basa quindi sulla mia esperienza diretta e sulla constatazione che il sistema carcerario non è in grado di offrire nessuna prospettiva di riscatto ai detenuti.
Sulla base di queste constatazioni ho da sempre avuto la necessità di cercare soluzioni alternative alla pratica della detenzione, che potessero offrire un reale percorso di rieducazione ai detenuti e contribuire al miglioramento della società in cui viviamo.
Mi apparve chiaro da subito che la detenzione era inadatta al compito di rieducare gli adulti e che molto più devastante lo era per i giovani. Lasciai quindi la cappellania dell’IPM (Istituto Penale Minorile) in segno di protesta contro il modello carcerario attuale quale strumento idoneo ad affrontare un problema di natura antropologica, pedagogica e sociale. Presi una decisione che mi tolse dall’animo un gran peso: se il carcere era illogico, violento, costoso e incapace di risolvere un problema di natura educativa e sociale bisognava impegnarsi per creare un’alternativa. Plasmammo così un modello di accoglienza nel quale riversare tutta l’esperienza maturata negli anni precedenti. Quel modello si chiama oggi “La Collina” ed è una comunità fondata ormai ventotto anni fa per accogliere minori e giovani adulti condannati in via definitiva dalla magistratura penale per reati anche gravissimi. Sorge a pochi chilometri da Cagliari nell’amabile campagna sarda. Ai ragazzi ospiti della comunità offriamo vita in comune, relazione, confronto continuo e un reale percorso di reinserimento, fondato sul duro lavoro e la responsabilizzazione. In un paesaggio fatto di ulivi, vigneti e di bellezza che li aiuta a ritrovare dentro sé quegli spazi che non sapevano di avere e che consentono loro di rielaborare la propria vita precedente sottraendoli al giogo della recidiva. Una comunità che non è solo il frutto di un mio disegno ideale ma di tutti coloro che ci hanno lavorato e che ci lavorano, condividendo con me un’idea di fondo: che nessuno nasce sbagliato, nessuno nasce deviante. Semmai lo si diventa. Il risultato? Quattro ragazzi in tutto, sugli oltre cento che abbiamo accolto nell’arco di 28 anni, sono tornati in carcere.
La nostra comunità è rivolta ai giovani adulti tra i 18 e i 25 anni che sono stati condannati a provvedimenti penali quando erano ancora minorenni, e che hanno il permesso dell’autorità giudiziaria di usufruire di misure sostitutive o alternative alla detenzione. Questi giovani devono completare un programma di rieducazione e riabilitazione che è già stato avviato in istituti di pena o altre comunità. In casi eccezionali, se è possibile un percorso educativo e di reinserimento socio-lavorativo, possiamo accettare persone che superano i 25 anni d’età. In alcuni casi, giovani che hanno terminato il periodo di espiazione penale ma che non sono ancora completamente autonomi, possono essere accolti per favorire il loro primo reinserimento sociale.
Per essere accolti nella nostra comunità educativa, i giovani detenuti devono seguire un percorso che spesso nasce dal desiderio del detenuto di venire a contatto con la nostra struttura. L’educatore o l’assistente dell’Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna, ci illustra la situazione giudiziaria del giovane e la sua condotta durante la detenzione al fine di poter valutare se sia idonea entrare nella comunità o meno. Il giovane deve anche dimostrare di essere disponibile a lavorare perché La Collina si autofinanzia in parte grazie al lavoro dei ragazzi e degli operatori. Se la valutazione è positiva, l’inserimento si articola in due fasi: “conoscenza” e “pre-accoglienza”. Nella fase di conoscenza, il giovane sperimenta lo stile di vita comunitario e si fa un’idea delle regole che governano il funzionamento della comunità. La fase pre-accoglienza prevede che il ragazzo soggiorni in Collina per tre mesi e partecipi a pieno titolo alla vita comunitaria, durante i quali si svolge una verifica intermedia. Alla fine di questa fase, si valuta l’eventuale inserimento stabile del giovane, si definisce il piano educativo individualizzato e si concordano ruoli e compiti con i servizi coinvolti.
La comunità offre l’opportunità di lavorare nell’azienda agricola della cooperativa, sviluppando una nuova visione di sé e diventando consapevoli delle responsabilità che ne derivano. Il lavoro agricolo permette loro di prendere coscienza delle proprie capacità e di contribuire al proprio sostentamento. Il lavoro diventa un antidoto alla depressione e alla disperazione, poiché insegna ai ragazzi a valorizzare ciò che hanno guadagnato col sudore della fronte. L’agricoltura non è l’unica forma di attività per i ragazzi, ma è un passaggio essenziale per mettere a frutto le proprie attitudini e potenzialità. La comunità mira anche a sviluppare l’autonomia e l’indipendenza dei ragazzi, che imparano a diventare consapevoli del fatto che sono i protagonisti del loro reinserimento. Questo è il nostro modello di società giusta ed attenta ai bisogni di tutti, soprattutto dei più deboli.
di Maria Antonietta Farina Coscioni
E ora? Dopo i giorni di commozione e indignazione seguiti alla drammatica denuncia e morte del giornalista Franco Di Mare, inviato di guerra in quei Balcani sconvolti dalla guerra e dove esplodevano ordigni carichi di uranio impoverito, e per questo ha respirato micidiali micro-scaglie che gli hanno procurato un incurabile mesotelioma? La coltre di silenzio è scesa, ancora. Clamorosa è stata la rivelazione del giornalista sul suo stato di salute a Che Tempo Che Fa. Vicenda resa ancora più amara dall’assenza mostrata dai chi avrebbe dovuto prontamente rispondere alle numerose sollecitazioni del giornalista che si è sentito negare perfino l’elementare diritto del rilascio dello stato di servizio.
C’è da chiedersi se quello di Franco Di Mare sia un caso isolato: giornalista televisivo ha lavorato con operatori di ripresa, montatori, tecnici; anche loro hanno “respirato”? Che controlli e che tutele? E senza andare troppo lontano, nei Balcani: basta restare a Roma. Il grande palazzone di viale Mazzini, sede della RAI, si sa da sempre che è carico di amianto. Lì lavorano e hanno lavorato centinaia di persone, gli stessi vertici dell’azienda…
È stato un vero e proprio “j’accuse”, quello dell’avvocato Ezio Bonanni, legale di Di Mare: “Il codice etico della Rai avrebbe imposto un diverso tipo di comportamento. Ma questo lo vedremo nelle competenti sedi giudiziarie. Ci sarebbero almeno altre due persone che hanno lavorato con Di Mare quando era inviato di guerra, e che manifestano sintomi di una malattia respiratoria, persone malate di mesotelioma in Rai che noi come Osservatorio Nazionale Amianto stiamo seguendo”.
È una vicenda che al di là del caso Di Mare, ha dimensioni inquietanti. L’Italia è piena di amianto ormai fuori legge che, se scalfitto, diventa letale. Da anni centinaia di lavoratori e le loro famiglie ne sono vittime, gli esperti calcolano che i picchi dureranno almeno fino al 2050.
Da parlamentare radicale già nel 2009 ho lanciato l’allarme su questa emergenza. In più di un’occasione denunciavo, sulla scorta di dati ufficiali del CNR, che nelle città italiane “vi sarebbero almeno 32 milioni di tonnellate di amianto da smaltire, due miliardi e mezzo di metri quadrati di coperture in eternit, pari a una città di 60 mila abitanti, fatta di solo amianto. Miliardi di fibre che, sino a quando non verranno smaltite continueranno a essere una bomba sotto la quale l’Italia siede inconsapevole e inerte: una situazione che provocherebbe la morte di circa tremila persone ogni anno per malattie correlate all’esposizione all’asbesto, e tra queste almeno milleduecento casi di mesotelioma”.
Una situazione gravissima, un vero e proprio attentato alla salute della collettività. È cambiato qualcosa, da allora? Ancora oggi si scontano inerzie, indifferenze, ritardi. Nel corso del mio mandato parlamentare ho presentato decine di interrogazioni con dati, cifre, situazioni precise. Ho ragione di credere che si potrebbero tranquillamente presentare anche oggi, senza mutare pressoché di una virgola.
Ricordo quanto dichiarò l’allora responsabile del Registro Nazionale dei mesoteliomi presso l’istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, il dottor Alessandro Marinaccio: “Stanno venendo a galla migliaia di storie che riguardano le più disparate categorie professionali. Sono situazioni ancor più drammatiche perché chi si ammala non aveva nessun tipo di consapevolezza, credevano di aver lavorato o vissuto in un ambiente ‘sano’”; non lavoravano direttamente l’amianto, ma l’amianto stava e, in molti casi, sta ancora, lì dove si guadagnavano da vivere, o dove vivevano: nelle onduline, nei capannoni, nei cassoni per l’acqua, nelle coibentazioni selvagge che andrebbero asportate e sepolte”.
Voglio ringraziare, ovunque sia, Franco Di Mare che ha sollevato la questione e coraggiosamente ha lanciato un prezioso messaggio a tutti noi e ai malati come lui in particolare: giocarsi la vita fino alla fine, avere fiducia nella scienza e nella ricerca: quello che oggi non appare curabile, e che porta ancora alla morte, un giorno, si spera non troppo lontano, lo sarà. Una cosa è certa: l’immobilismo produce sempre situazioni sconcertanti, inaccettabili, produce morte. È questo il “mostro” che dobbiamo, con chi vorrà esserci, sconfiggere.
di Guido Salvini
Le “pagelle” proposte come risoluzione dei problemi della magistratura o al contrario evocate come riduzione della sua indipendenza, non serviranno, anche se dovessero essere approvate, praticamente a nulla. Quando al test Minnesota Multiphasic Personality, che dovrebbe, forse, essere utilizzato, ha uno scarso valore predittivo sul lungo periodo se non accompagnato da un costante percorso diagnostico, ha una vera funzione solo quando colui al quale è somministrato ha una compliance, cioè, intende risolvere i suoi problemi psicologici o psichici, si trovano anche su Internet i manuali per rispondere in modo “corretto” alle domande trabocchetto. Comunque, come sembra, tutto sarà gestito addirittura all’interno del Consiglio Superiore della Magistratura. Un marchingegno inutile. Il problema in realtà non sono i “mattoidi” nella magistratura, anche se alcuni ne ho conosciuti, ma le forme di reclutamento dell’intera categoria.
Oggi ragazzi di 27-28 anni che hanno avuto la capacità o la fortuna di scrivere bene tre temi di diritto sono ritenuti idonei a giudicare i loro simili in ogni aspetto, tra il civile e il penale, della loro vita personale, sociale e produttiva, e questo per sempre perché le verifiche successive delle capacità dei magistrati in realtà non esistono. Così in una funzione di potere vero, che spesso comporta sin dall’inizio, dalla vittoria del concorso, una dilatazione dell’Ego, entrano giovani senza esperienze di vita e di lavoro, spesso poco rispettosi di chi hanno davanti, spesso deboli in quella cultura generale che va dalla psicologia alla sociologia, dalla storia alla medicina, necessaria tutte per comprendere sia situazioni personali sia fenomeni sociali complessi.
Rimangono nella maggioranza dei casi burocrati della giustizia non incentivati a migliorarsi e in altri casi, che tutti ben conosciamo, magistrati spinti soprattutto dalla vanità e dalla conquista di potere e di successo personale. In altri paesi europei la selezione di chi, come il magistrato, siede più in alto di tutti gli altri, è ben più affidabile: il concorso non è unico e istantaneo ma vi sono nel tempo più livelli di prova accompagnati da anni di corsi di verifica in modo da selezionare, sotto ogni profilo, veramente i migliori: è questo percorso il vero test.
Di un progetto serio di riforma del reclutamento in Italia non si parla neanche, ci si scontra solo su sciocchezze che sono il riflesso della guerra infinita tra politica e magistratura. Quanto alle pagelle dei magistrati non credo che l’acquisizione dei provvedimenti, siano tutti o a campione, cambierà nulla. Si accatasterà, in cartaceo o informatico, una massa gigantesca di atti e di sentenze che probabilmente nessuno leggerà.
Chi vive al di fuori del concreto funzionamento della carriera della magistratura stenta a comprendere che quelli che contano davvero sono i pareri che, per ogni step di valutazione di un magistrato, i capi degli uffici approntano per i Consigli giudiziari, i piccoli CSM costituiti in ogni Corte d’appello che inviano poi il fascicolo a Roma. Per inciso, per essere eletti nei Consigli bastano poche decine di voti procurati dalle correnti acquisendo così, con ben pochi meriti, il diritto di giudicare tutti gli altri magistrati.
È proprio con questi pareri che i compiaciuti capi degli uffici sponsorizzano i loro campioncini, pareri pieni di giudizi roboanti, retorici e immaginifici in cui ogni magistrato risulta aver dimostrato capacità eccezionali e ha una statistica di sentenze e provvedimenti superiore alla media, tutti superiore in evidente contrasto logico con le leggi della matematica. Entrano qui in gioco non solo le militanze correntizie ma anche l’appartenenza del singolo al cerchio magico che si è formato intorno al capo e forme varie di nepotismo. È qui, con gli input dei Consigli Giudiziari, che si preparano e confezionano le future carriere di successo e non credo proprio che con i correttivi, peraltro tortuosi, previsti dal disegno di legge possa cambiare qualcosa.
Quanto alle censure nei confronti dei magistrati, soprattutto Pubblici Ministeri, che sono andati incontro ad una serie di insuccessi mi chiedo come si possa pensare ad una reale selezione se gli accusatori che hanno condotto con inutile pervicacia indagini come quella Stato–Mafia o Eni–Nigeria, con conseguenze terribili per chi è stato per anni imputato e per l’immagine del Paese, non solo non sono stati spostati a incarichi più defilati ma in alcuni casi sono stati anche promossi ad incarichi superiori e prestigiosi.
Altrettanto insignificanti sembrano destinati a essere gli esiti della tanto promessa riduzione della quota dei magistrati fuori ruolo, in spregio alla loro introduzione nel potere esecutivo, che potrebbero essere sostituiti quasi sempre da validi funzionari di carriera, senza aggravare tra l’altro l’impressionante scopertura degli organici della magistratura. Alla fine, il numero dei magistrati fuori ruolo sarà ridotto solo di una ventina di unità: tutto è differito comunque al 2026 e soprattutto i limiti temporali varranno solo per coloro che saranno collocati fuori ruolo a partire dall’entrata in vigore del decreto, salvando così quelli che sono già da tempo fuori dalle funzioni giudiziarie. Conosco a Milano, una sede che certo ha bisogno di magistrati in udienza e non a Roma, il caso di chi è fuori ruolo di 15 anni e, distaccato presso una Commissione parlamentare, non rientra in servizio nemmeno quando tra una legislatura e l’altra la Commissione che dovrebbe impegnarlo in pratica non esiste. Ho conosciuto bene anche un capo a mezzo servizio in quanto dedicava alla sua presenza in ufficio assai meno tempo rispetto ai corsi che teneva da anni all’Università Cattolica.
D’altro canto, il Ministro di Giustizia non ha dato certo il buon esempio perché si è circondato, quali dirigenti dei vari uffici apicali, di magistrati da lui prelevati personalmente dal ruolo della magistratura, confermando la storica e ambigua commistione in quel Ministero, così come in altri, tra potere esecutivo e potere giudiziario.
In sostanza assisteremo nei prossimi mesi alle solite battaglie inutili come quelle tra le rane e i topi, la futile Batracomiomachia della commedia greca, utili solo a dare visibilità ai personaggi che intervengono per l’uno e dell’altro schieramento. Non saranno certo test e pagelle a cambiare il “sistema”, in senso sociologico, della magistratura, che non funziona e continuerà, ne sono convinto, a non funzionare se non per soddisfare i desideri di pochi eletti.
di Otello Lupacchini
Correva l’anno 1970, quando, ancora pargolo pieno d’ambizioni, assistetti alla proiezione de I Cannibali, film di Liliana Cavani che meglio sia de I pugni in tasca, firmato nel 1965 da Marco Bellocchio, sia di Marcia nuziale di Marco Ferreri, approdato nelle sale nel 1966, riflette il momento, in cui, negli anni Sessanta, la rivolta giovanile, fattasi sociale, si rivolgeva contro i padri, senza tuttavia rimanere chiusa nella famiglia, essendosi l’accusa estesa ben presto all’intero ordine sociale, assumendo tonalità globali, ideologiche e politiche: erano anche gli anni di Easy Rider e di Fragole e sangue.
La vicenda narrata nel lungometraggio della cineasta carpigiana si svolge in una metropoli laboriosa e ordinata, ingombra, però, dei cadaveri dei giovani di una qualche rivoluzione fallita, scavalcati dalla folla, che silenziosa, indifferente, civilmente affaccendata, sembra quasi non vedere quei corpi. L’ordine è, infatti, di non toccarli, perché servissero da esempio. La protagonista del racconto, figlia di borghesi benestanti e fedeli al regime, intenzionata a dare sepoltura al fratello, viene ben presto catturata dalla polizia, messa sulle sue tracce proprio dagli stessi familiari. Soltanto il fidanzato della giovane donna, figlio del primo ministro, tenta inutilmente d’intercedere, accusando il padre d’assassinio. Tragico l’epilogo: mentre la protagonista finisce uccisa, il fidanzato, rinchiuso in manicomio, si degrada a livello animalesco.
Affatto evidente che si trattasse di una rilettura in chiave contemporanea della tragedia Antigone di Sofocle. Nel testo del teatro greco, dei quattro figli di Edipo e Giocasta, i due maschi, Eteocle e Polinice, si uccidono a vicenda in una guerra civile; il cadavere di Polinice, giace insepolto fuori dalle mura di Tebe, perché resosi colpevole di aver marciato con un esercito contro la città, essendo stato escluso dal trono della stessa, nonostante l’accordo fissante un’alternanza tra lui e il fratello; a Eteocle, per contro, è stata concessa sepoltura; per Antigone la situazione è intollerabile, sia perché suonante offesa al corpo di Polinice, ma soprattutto perché in violazione della giustizia divina, da lei sentita e custodita, tale, dunque, da imporre la sepoltura dei propri familiari; eccola, dunque, disubbidire per due volte, recandosi nottetempo a ricoprire i resti del fratello, ma scoperta e denunciata, ineluttabile la sua condanna, da parte di Creonte, a una pena durissima: essere rinchiusa in una caverna e lasciata morire; la fanciulla rivendica il proprio atto e accetta la condanna, ma una volta rinchiusa si uccide; alla notizia della sua morte si uccide anche il suo promesso sposo, Emone, figlio dello stesso Creonte e di Euridice. L’attualizzazione, nell’opera cinematografica, della trama della tragedia ha comportato significative modifiche al testo di riferimento, che muovono verso altre direzioni e tali da cambiare radicalmente la valenza stessa del gesto della protagonista. In particolare, l’Antigone de I cannibali non è la figlia di Edipo e Giocasta o, almeno, non lo è nella valenza drammatica in cui lo è esserlo nella tragedia sofoclea, dove il rapporto incestuoso tra madre e figlio ha dato origine a una discendenza “macchiata” dalla colpa del padre; non è, dunque, sorella di Polinice nella “mostruosa” maniera del mito greco, eliminando quindi del tutto le problematiche legate ai rapporti di parentela, fondative e fondanti del testo tragico; inoltre, le motivazioni del gesto della protagonista del film, i cui genitori sono ancora vivi, si allontanano completamente da quelle del suo corrispettivo letterario: l’Antigone del racconto cinematografico non compie il rito della sepoltura per aderire a leggi divine o perché, morti i genitori, non potrebbe più nascere un altro fratello, come afferma, invece, l’Antigone sofoclea alla fine della tragedia, ma lo compie perché per lei è naturale, così com’è naturale reiterare il gesto; ecco perché l’Antigone del film non si pone nemmeno il problema delle ripercussioni delle sue azioni e non ricerca ossessivamente la morte, in quanto figlia di generazioni corrotte che possono trovare risoluzione solo nella fine della propria vita.
Analogo discorso vale per Creonte, che nel film diviene un anonimo Primo Ministro, ben lontano dal tiranno della tragedia, il quale rappresenta la legge di Stato che si contrappone a quella morale; non lascia insepolti i ribelli poiché ritenuti traditori, ma per fare dei loro corpi dei simboli del proprio potere, moniti fisici di una politica non in grado di mantenere fino in fondo l’ordine costituito; il coro, peraltro, rappresentazione viva, nella tragedia, della voce del popolo, unico “corpo” in grado di parlare al sovrano in maniera diretta, consigliandolo o mettendolo in guardia, diviene invece nel film un insieme di corpi morti, meno scomodi e più incisivi; e se a suo figlio, nella pellicola, viene tolta la possibilità di redimersi nella morte, a lui non viene concessa nemmeno la possibilità di un pentimento, laddove nel testo sofocleo decide di provare a salvare Antigone, spinto dal coro e da Tiresia, che lo mettono in guardia dalla furia delle Erinni.
A causa del cambio di prospettiva operato da Liliana Cavani, persi inizialmente di vista il senso autentico del testo letterario di riferimento. “Innamorato” dell’Antigone cinematografica, complice magari la convincente interpretazione del personaggio offerta dalla splendida attrice svedese Britt Ekland, ma anche intrigato dal tronfio e altero, ombroso, suscettibile e sospettoso Primo Ministro/Creonte, personaggio dal comportamento tracotante, interpretato da Francesco Leonetti, che si pavoneggia, si ascolta, si ammira, senza mai ammettere i suoi torti, esibendo piuttosto i gravi difetti del suo carattere, quali l’orgoglio smisurato, l’arroganza, il comportamento tracotante, avevo finito per non cogliere il significato metaforico del contrasto fra i due personaggi. Poco male: avrei avuto ben presto occasione di porre rimedio alla superficialità del mio originario approccio interpretativo all’Antigone sofoclea.
Pur non essendo il tragediografo greco un filosofo e quantunque ai suoi versi non debba attribuirsi valore che non sia poetico, in essi la forza della poesia ha, però, raffigurato meglio che in qualsiasi trattazione filosofica uno dei problemi fondamentali della filosofia del diritto, tanto da parlarsene nelle aule universitarie, per le parole di Antigone, la quale, condotta al cospetto del re, che le chiede se abbia osato trasgredire le sue leggi, risponde: “Sì; perché certo non è stato Zeus ad emanare questo editto; e la Giustizia, che dimora con gli dèi sotterranei, non ha mai stabilito per gli uomini leggi simili. Ed io non ritenevo che i tuoi bandi avessero tanta forza che un mortale potesse soverchiare le leggi non scritte (àgrapta nómina) ed incrollabili degli dèi. Perché queste non vivono oggi o ieri, ma in eterno, e nessuno conosce il momento in cui ebbero origine” (vv. 450-457).
Nei primi anni Settanta dello scorso secolo, infatti ci s’interrogava ancora sull’esistenza di leggi naturali” anteriori e superiori a quelle poste dallo Stato; ci si chiedeva ancora, almeno tra i giuristi degni di tale nome, se l’uomo possieda “per natura” diritti che le leggi dello Stato debbano rispettare; e quali siano queste leggi e questi diritti “naturali”; se, là dove esistenti e conoscibili con certezza, siano immutabili o varino col tempo; se sia lecito e doveroso disobbedire alle leggi contrastanti col diritto “naturale”; se i giudici debbano applicare la legge dello Stato quando questa appaia loro ingiusta. Era viva, insomma, la consapevolezza che non per caso, nella nostra Costituzione, si facesse carico alla Repubblica di “riconosce(re) e garanti(re) i diritti inviolabili dell’uomo” (art. 2): gli anni che avevano preceduto l’emanazione della legge fondamentale avevano veduto legislazioni positive, dunque legalissime, cioè affatto conformi all’ordinamento dello Stato che le aveva emanate, le quali privavano i cittadini di molti importanti diritti o che li limitavano grandemente, cominciando da quello che tutti li riassume: il diritto di libertà. Da allora tanta acqua è passata sotto i ponti. La figura di colei che racchiudeva in sé ogni virtù, di colei che rappresentava un modello insuperato di chi si oppone a un regime tirannico, di chi reagisce di fronte ai diritti calpestati e negati, di ogni donna in lotta contro il potere maschile, per la sua determinazione a dare sepoltura al fratello Polinice, violando la legge cittadina per obbedire a una legge non scritta, è sembrata non corrispondere più al personaggio cui Sofocle ha dedicato l’omonima tragedia oltre 2500 anni. Là dove, purtroppo, oggi più che quella di Antigone a intrigare è la figura di Creonte, di cui balzano evidenti i grandi difetti di carattere: orgoglio smisurato, arroganza, comportamento tracotante. Tronfio e altero, si pavoneggia, si ascolta, si ammira, non ammette né i suoi torti né i suoi difetti. E poiché vanità e diffidenza vanno di pari passo, è ombroso, suscettibile, sospettoso. Dietro la maschera autoritaria e grossolana, sotto l’altezzosità rabbiosa, carica di beffardo cinismo, di Creonte, si nasconde, però, un inconscio sentimento d’inferiorità che lo domina lungo tutto l’arco della tragica vicenda. Ed è in questo motivo profondo e occulto che si rinvengono le radici delle forme esasperate del suo comportamento, di quel suo orgasmo, della sua smania, della sua febbre inesausta di vendetta. Il suo dramma è appunto il dramma di questo sentimento e dei suoi sforzi per superarlo. Egli è, in fondo, un debole che diventa autoritario e assume l’aria di forte per difendersi dalla propria debolezza.
Ebbi a sostenere questa tesi eterodossa, per vero un tantino isolato, già alcuni anni or sono, oggi essa è confortata da una grecista fin troppo accreditata, Eva Cantarella (Contro Antigone o dell’egoismo sociale, Torino, Einaudi, 2023), la quale, esplorando la distanza tra mito e personaggio, mette in luce lati sorprendentemente negativi dell’eroina da tutti osannata, arrivando a contestare il ruolo di despota attribuito a Creonte. Quanto all’aver prospettato, da parte della professoressa Cantarella, un’assurda attualizzazione del protagonista di una drammatica vicenda umana e politica che lo rende una figura non meno interessante e non meno tragica, identificato, ahimè, con Matteo Salvini. Un vero peccato: è qui, purtroppo, che casca l’asino.
di Salvatore Sechi
Guido Salvini è un magistrato alieno. Ha concepito il suo lavoro come una missione etica, cioè una vocazione per amministrare la giustizia senza guardare in faccia a nessuno. Soprattutto se si trattava di poteri (e Dio non avesse voluto) magistrati forti.
La casta giudiziaria anche quando trasuda aromi di sinistra non di rado è un epifenomeno di chi guida il vapore. Non ha potuto sopportare un simile affronto. Pertanto, ha considerato Salvini come un intruso poco compiacente, addirittura scorbutico, se non proprio un corpo estraneo all’esuberante corporazione. Ma come portare avanti un disegno dal respiro punitivo e sanzionato rio nei confronti dell’audace magistrato?
Riconosciamolo, non era facile. Salvini non ha mai sgomitato per accreditarsi in qualcuna delle correnti fibrillanti e fameliche del mondo dei giudici descritte da Palamara. Per di più si è sempre distinto per essere stato sempre ligio al dovere. Quasi da workalcoholic, negli ultimi anni era possibile trovarselo tra i piedi in ufficio tutte i sabati e tutte le domeniche. E spacciava insopportabili virtù come quella di non aver mai chiesto di fare il capo-ufficio né perorato un trasferimento in un ufficio di prima linea.
A dicembre ha lasciato l’incarico di Gip. Se n’è andato in pensione fino a prova contraria senza misure cautelari pendenti, nessuna intercettazione, archiviazione e sentenza fuori termine. E con tutti i processi di rilievo per la collettività o conclusi o fissati. Per tacere sulla mancanza di lamentele o solleciti da parte di pubblici ministero, avvocati difensori o imputati.
Al Corriere della Sera (e a chi ne ispira il patetico e melenso soliloquio) questi meriti non vanno giù. Qualche cronista di giudiziaria non ci dorme proprio sopra. Non a torto dal momento che Salvini ha chiuso la porta del Tribunale di Milano con 80 giorni di ferie arretrate, mentre l’amministrazione faceva il braccio corto lesinando sui compensi di chi è alla sbarra dal 2017.
Tutto ciò poteva essere rubricato come un tran-tran reciprocamente accettato tra il vertice e la base della cupola milanese della giustizia. A mettersi di mezzo è stato il fatto che sul tavolo di Salvini sono stati fatti rotolare affaires importanti. Dalla strage milanese di Piazza Fontana al caso Moro, dal tentacolare processo sul Monte dei Paschi, da ingorghi di mafia della cosca Aquilano fino alla loggia Ungheria, per non parlare dei trapper e delle violenze degli ultrà interisti. E invece di cucinarli come un brodino romagnolo per fare anche una micro-carriera, ha voluto rompersi la testa allargando area e contesto di corruzioni, aggressioni, occulte satrapie, fino a scervellarsi cercando esecutori e mandanti. Né si è fatto scrupolo di prendere cappello contro inchieste e cruciverba di altri suoi colleghi, per di più enfiati come rane dai mass media cartacei e dalla Tv.
Effettivamente il troppo stroppia. Tutto l’establishment milanese, veneziano e romano nel 2019 ha fatto scorrere fiumi di champagne all’annuncio che Salvini avesse affidato le sue memorie di anni tenaci di lavoro ad un volume, La maledizione di Piazza Fontana, edito da Chiarelettere. Appena qualche esemplare arrivò sui banconi delle librerie gli eccellentissimi giudici biascicarono in una smorfia ridente un funereo “Parce sepulto”.
A sera Telecom dovette registrare esondazioni e effluvi di telefonate. Inorriditi e tremuli lamentavano che in quelle 600 pagine circa in cui Salvini documentava di non aver trovato nei suoi colleghi milanesi un seguito alle sue indicazioni su delitti di stato, misteri di mafia, terrorismo, colpi di mano, ecc., c’era poco da eccepire. Erano capitoli feroci, ma ahinoi impeccabili. Nessuna denuncia e neanche contestazione fu distillata dalle fortezze giudiziarie, imperscrutabili fonti di verità, sparse tra Lombardia, Pie monte, Veneto e Lazio.
Ora, con l’andata in pensione di Salvini, scatta l’ultima rabbiosa vendetta. Un linciaggio vero e proprio. Forse è il caso di richiamare l’attenzione del presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Può un giudice imperterrito, che ha onorato l’indipendenza e la professionalità del ceto giudiziario, essere sottoposto ad una violenza diffamatoria come quella scatenata dal Corriere della Sera? Può l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia non aprire un’indagine sul fondamento delle accuse mosse a Salvini da un suo iscritto? Possono ex direttori e collaboratori del quotidiano milanese come Ernesto Galli della Loggia, Paolo Mieli, Ferruccio De Bortoli, Antonio Polito, Giovanni Bianconi tacere, cioè non chiedere spiegazioni motivate a Luciano Fontana, su quella che, dopo tre mesi dal pensionamento, appare non una notizia di cronaca, ma come una sorta di aggressione contro uno dei migliori e più coraggiosi magistrati italiani?
di Farrokhi Bahram
La recente morte di Ebrahim Raisi ha riaperto il dibattito politico in Iran, offrendo ai riformisti una nuova opportunità di competere nelle imminenti elezioni presidenziali. La presenza dei riformisti al potere è un elemento cruciale per l’implementazione del nuovo accordo JCPOA 2, attualmente in fase di attuazione.
Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e i democratici devono affrontare la sfida di frenare il programma nucleare iraniano per consolidare il proprio successo elettorale. In seguito all’ultimatum di Biden – «Gli Stati Uniti non permetteranno al regime islamico di ottenere una bomba nucleare in alcun modo» – il regime iraniano si trova a dover negoziare un accordo con l’Occidente per superare l’impasse politica ed economica in cui è intrappolato.
Il primo passo verso questa direzione è stato compiuto con la nomina di Ali Bagheri Kani, un parente della Guida Suprema Ali Khamenei, a Ministro degli Affari Esteri. Questa mossa potrebbe essere interpretata come un tentativo del regime di mostrare apertura verso il dialogo e la cooperazione internazionale, pur mantenendo salda la propria influenza interna.
La situazione politica in Iran resta quindi fluida e complessa, con implicazioni significative per le dinamiche regionali e internazionali. Sarà cruciale osservare come i riformisti sfrutteranno questa finestra di opportunità e come l’amministrazione Biden gestirà le delicate trattative per il futuro del JCPOA.
Il nostro amico Sergio Staino ci ha lasciato il 21 ottobre 2023. Una lunga malattia, sembrava essersi ripreso e invece quel giorno… l’amicizia con Sergio è nata molto prima di questa rivista; e quando, nel giugno del 2022 Maria Antonietta Farina Coscioni gli ha chiesto di collaborare – amichevolmente come era suo solito – con “Proposta Radicale” ha accettato con entusiasmo. Ha suggerito il titolo della sua rubrica, “Matita vagante”, che dice molto della sua personalità. Puntuale per ogni numero giungevano due-tre disegni lasciandoci liberi di “pescare” quelli che si riteneva più opportuni; il che ci procurava imbarazzo, perché tutti lo erano, sempre. Poi il lungo ricovero, un accenno di ripresa, infine la morte; la rubrica è diventata “Matita vagante amarcord”: volevamo ancora sentirlo con noi. Per questo legame che non si è interrotto, aderiamo con entusiasmo all’iniziativa lanciata dalla moglie Bruna e dai figli Ilaria e Michele, una campagna di crowdfunding chiamata “Satira e Sogni”. L’obiettivo è creare un portale on line accessibile a tutti che raccolga lo sterminato archivio di Sergio, renderlo disponibile e fruibile. I dettagli dell’iniziativa sono nella lettera di Bruna, che volentieri pubblichiamo con l’appello alle nostre lettrici, ai nostri lettori di contribuire per quello che possono.
Una lettera di Bruna Binasco Staino
Come forse già saprete è da poco partita “Satira e Sogni”, la campagna di crowdfunding per creare un portale accessibile a tutti, che raccoglierà l’archivio di Sergio. Era una sua volontà e ci teneva molto, che le sue storie, vignette, strisce e illustrazioni diventassero un bene comune. L’obiettivo è quello di raccogliere almeno 110.000 euro per coprire i costi di realizzazione della piattaforma digitale di “Bobo e dintorni”. I lavori sono iniziati già un anno fa, quando abbiamo raccolto, censito e avviato la digitalizzazione di oltre 20.000 opere di Sergio, affrontando costi elevati (più di 40.000 euro) grazie ai nostri risparmi e al contributo degli amici più stretti. Sta per partire la seconda fase del progetto che prevede la schedatura delle opere e la connessione di queste schede alle immagini per poi fare il caricamento sulla piattaforma e renderle accessibili a tutti.
Come ben capirete è un lavoro enorme e che richiede l’utilizzo di un sofwtare sviluppato appositamente per questo scopo. Non sarà facile e ci terrà impegnati per oltre un anno. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per portare a compimento questo sogno di Sergio. Ma siamo fiduciosi di farcela, perché abbiamo avuto la prova che l’amore per Bobo e per il suo autore è forte e diffuso.
Come potete aiutarci? Facendo una donazione, diffondendo la raccolta fondi tra i vostri contatti online e di persona, lasciando una testimonianza video da usare per le nostre comunicazioni online. Ogni contributo è prezioso e ci avvicina all’obiettivo. Spero di avere vostre notizie presto.
P.S. Se volete donare subito e direttamente all’Associazione potete farlo anche tramite il nostro IBAN IT26T0306938085100000011533 – INTESTATO a: Associazione Bobo e Dintorni, causale SATIRA E SOGNI
di Ted Baxter
C’è una bellissima fotografia – la si trova facilmente in Internet – ritrae tre grandi scrittori siciliani, Gesualdo Bufalino, Vincenzo Consolo, Leonardo Sciascia. È estate, sono alla Noce, l’amata contrada vicino Racalmuto dove Sciascia ama ritirarsi per scrivere i suoi romanzi; i tre seduti stretti sono contenti, ridono chissà per quale facezia o storia raccontata. È Giuseppe Leone che li coglie in quel momento di serena amicizia, un grande fotografo. Ci lascia a 87 anni, dopo una vita di scatti: sono, non si esagera, poesia per gli occhi. Vittima di quello che sembra un lieve malore e in poche ore si tramuta in tragedia. Era nato a Ragusa, il 24 dicembre 1936.
Leone è stato l’amico e il sodale dei maggiori scrittori del ‘900. Con la sua macchina fotografica aveva il dono e l’arte di trasformare la realtà in qualcosa di fantastico, senza snaturarla e tradirla. Le sue sessanta e passa raccolte d’immagini lo documentano e testimoniano. Nel suo studio sono custoditi centinaia di migliaia di scatti: un vero e proprio giacimento da esplorare e che riserverà mille bellissime sorprese. Le immagini, per inciso, quasi sempre riflettono il senso di umorismo profondo e discreto, raro del suo autore; così, pur non comparendo, diventa lui pure protagonista dei suoi lavori, “soggetto” con i soggetti ritratti.
Non solo. La sua è una fotografia “militante”, di testimonianza e denuncia: racconta i guasti e i danni di una malintesa modernità che trasforma e snatura con politiche industriali non calibrate e violente, che perseguono il mero accumulo di profitti e potere a scapito del progresso e del miglioramento del livello della vita dei cittadini. Il sogno e la speranza che diventano incubo. Le mostruosità degli insediamenti industriali che fanno scempio delle coste; le periferie delle grandi città che esplodono per un processo di inurbamento forzato, “selvaggio”, senza programmazione; le speculazioni edilizie dietro le quali lucrano e operano potenti e prepotenti clan delinquenziali e mafiosi, protetti dal supino potere politico. È tutto questo che anno dopo anno, “armato” della inseparabile Leica, Leone documenta.
Instancabile sul suo tavolo di lavoro ben tre progetti già quasi conclusi e che vedranno comunque la luce; in particolare, un volume dedicato al mondo dell’infanzia. Si può scommettere che ha affrontato questo tema non facile nel suo modo caratteristico che costituisce un unicum destinato a restare tale.
Sciascia gli è amico e lo stima. Lo segnala a Mario Andreose, direttore editoriale della Bompiani: “Caro Andreose, mi permetta di segnalarle un fotografo con bottega a Ragusa che sembra scivolato da una pagina di Brancati”. Insieme realizzeranno tre prelibatissimi volumi: La contea di Modica (Electa, 1983); Invenzione di una Prefettura (Bompiani, 1987), e assieme a Gesualdo Bufalino e Paolo Nifosi, Mastri e Maestri nell’architettura iblea (Amilcare Pizzi Editore, 1985). Ma Leone lavora con tantissimi altri grandi scrittori e letterati. Solo a mo’ di assaggio: Il Natale. Arte tradizione in Sicilia, con testi di Antonino Buttitta e Consolo (Guida); L’isola nuda, con testo di Bufalino (Bompiani); Anarchia equilibrata. Il barocco siciliano, con testo di Consolo (Edizioni Il Sole 24 Ore); La musica degli iblei, con testo di Matteo Collura (Bruno Leopardi); Madonie, con testo di Bruno Caruso (Bruno Leopardi), Sicilia Terra madre, con testi di Diego Mormorio e Mario Pintagro (Edizione Kalós)…
In un piccolo saggio, poi compreso nella raccolta Cere perse (Sellerio), Bufalino fornisce un eccellente ritratto di Leone. Una Kodak per Faust è il titolo.
“La fotografia è un peccato, probabilmente; è l’ottava empietà capitale. Se la creazione significa il declinarsi dell’informe in forme libere e varie, e il loro fluire infinito nella corrente del tempo, il flash che all’improvviso le paralizza non può che apparire un atto di trasgressione e di scandalo, né si dissolverà senza lasciarsi dietro un riconoscibile odore di zolfo. S’intravedono dunque le ragioni degli iconoclasti, di chi, dopo aver viziosamente collezionato istantanee per tutta la vita, le butta una sera nel caminetto. V’è un fondo di perversità nell’insistenza con cui ci sforziamo di catturare la luce e d’intrappolarla dentro un rettangolo di cartone. E il reprobo Faust ch’era disposto a vendere l’anima pur di fermare l’istante, chiederebbe oggi a Mefistofele non la gioventù ma una Kodak”.
Bufalino è intrigato, ammaliato da “un album di sassi, alberi, facce, gesti della mia isola, colti dall’occhio ladro di un eccellente fotografo di quaggiù, Giuseppe Leone, e introdotti da Leonardo Sciascia”.
L’opera in questione è La contea di Modica, preziosamente stampata da Electa:
“La contea di Modica è il nome storico della provincia dove sono nato e vivo, che è quella di Ragusa, la più meridionale d’Italia, con i fari delle sue coste rivolti a cercare l’Africa, dietro il breve braccio di mare, là dove sunt leones e se ne sente quasi il ruggito. Una provincia che gli altri siciliani chiamano babba, con un sorriso. Babba vuol dire bonaria, innocente, ed è epiteto meritato, se è vero che qui negli ultimi dieci anni il numero dei morti ammazzati è vergognosamente basso, rispetto a qualunque altro sito dell’isola. Di questa possibile Arcadia, santuario artigiano e rurale di saviezza, misura e fantasia, triangolo di luce greca, insediato dalla pece levantina e cartaginese, le 116 fotografie del libro ripetono memorie, allegrie, lutti, giochi, arie di vita.
Sono le stesse arie che io ho respirato e respiro, eppure quante novità m’insegna, sulla soglia, il saggio di Sciascia, con quella sua eroica magrezza di stile, e l’affabulante procedere per guadagni minuscoli e decisivi, fino a raggiungere l’osso delle cose, da inquisitore paziente, che fa cantare i documenti come brigatisti pentiti. E quanto altro imparo dai fotogrammi fulminei che Leone ha saputo strappare al mobile carosello dell’esistente, conferendogli stemma di verità. Alcune immagini sono memorabili: di un giocatore di fiera davanti a una platea di bambini diffidenti, ingordi, ipnotizzati, il quale, mentre agita i bussolotti nel pugno, abbassa volpinamente sugli occhi le palpebre; di ragazzi che s’inseguono lungo le scale di una chiesa, e l’obiettivo li atteggia in graziose movenze di danza; di grandi carrubi solenni; di campagne calcinate, dove i muretti di sassi, mentre disegnano i confini obbligati dell’economia proprietaria, sembrano tuttavia obbedire a un progetto di gratuita bellezza, e comporre, non si sa come, un ikebana di architetture e sculture rupestri.
Morbida, forse troppo, la temperie in cui queste apparizioni si bagnano. Non c’è qui posto per i gibbi calvi, i bivieri polverosi, le trazzere storte; nessuna madre veglia i cadaveri, eccellenti o no, della Sicilia più nera. Evidentemente il fotografo (che con questa e le opere precedenti si aggiunge ai maestri dell’odierna fotografia siciliana, da Sellerio a Scianna), ha compiuto una scelta di cui non lo ringrazieremo abbastanza, essendo la sua testimonianza complementare alle altre, e insieme a queste necessaria per chi pretenda un’esauriente idea storica e umana dell’isola. Si sa che la Sicilia è plurale, che il Regno delle Due Sicilie avrebbe dovuto chiamarsi delle Dieci, delle Cento Sicilie. Crocevia e ombelico ambiguo del mondo, amalgama di razze e vicende diverse, la Sicilia non ha mai smesso di essere un grande ossimoro geografico e antropologico di lutto e luce, di lava e miele”.
Era facile da trovare, Leone. Il suo studio-galleria sulla salita di Corso Vittorio Veneto, vicino alla cattedrale di San Giovanni Battista, un luogo conosciuto da tutti i ragusani. Da lì, paziente, metodico, un continuo esplorare paesi e villaggi dell’isola, un incessante scattare immagini e così documentare come il passato si trasforma in presente; il bene e il male della civiltà contadina che si inurba, vai a sapere se in progresso che contiene i germi di un inevitabile e contestuale regresso. Perché certamente il livello di vita migliora, ma a prezzo di un livellamento e di un’omologazione inquietante; l’abbandono delle campagne, i centri storici stravolti, i paesaggi sfregiati, speculazioni di ogni tipo, imbarbarimento dell’animo. C’è di tutto, in quell’enorme giacimento di memoria e ricordi che è l’archivio Leone.
L’incontro decisivo con Sciascia, quasi un caso. Leone ha terminato il suo primo lavoro, La pietra vissuta, pubblicato da Sellerio. Enzo, il grande fotografo ed editore gli presenta una persona che in una saletta della casa editrice legge e fuma: Sciascia, appunto. Lo scrittore chiede a Leone se conosce la prefettura di Ragusa. Leone risponde di sì. Sciascia si riferisce alle tempere realizzate da Duilio Cambellotti che adornavano il palazzo prefettizio. Sciascia si propone un lavoro su quelle pitture. Qualche anno dopo Bompiani pubblica il sontuoso Invenzione di una prefettura, testo di Sciascia, immagini di Leone. Da quel gioco di equivoci è nata una fantastica, rara, amicizia.
di Gualtiero Donati
Due registi, Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi, raccontano come brutalità della repressione dei regimi; al tempo stesso dimostrare come sia possibile una “resistenza” che faccia leva sull’umanità e la solidarietà.
Zar Amir (iraniana) e Guy Nattiv (israeliano) è quella che si può definire una “rivelazione”. Tatami racconta la storia della campionessa Leila e della sua allenatrice Maryam durante i mondiali di judo in Georgia. Gara apparentemente sportiva (rappresentata in ogni minimo dettaglio); in realtà si spazia su orizzonti ben più complessi, conflitti che esplodono quando Leila deve affrontare la collega israeliana. Uno e il regime islamico cerca di bloccare l’incontro con un pretesto. La vicenda è la metafora di un regime oppressivo e fanatico che opprime un popolo e in particolare le donne. Sapiente il montaggio delle storie di vita di atleti e artisti costretti a fuggire dal paese. Il tutto nelle parol
e di Nattiv e Ebrahimi: “Gli artisti israeliani e iraniani hanno trovato i loro fratelli e sorelle incontrandosi nell’arte e hanno scoperto di essere in realtà molto vicini e di avere tantissime cose in comune, condividendo l’arte stessa, l’estetica, il cinema… In definitiva, speriamo di aver fatto un film che mostri al mondo che l’umanità e la fratellanza vincono sempre”.
Zar Amir Ebrahimi, iraniana, regista e attrice ha vinto nel 2023 la Palma d’Oro a Cannes per Holy Spider, thriller ibrido: storia di una giornalista che da Teheran si sposta nella città santa di Mashhad per indagare su un serial killer che uccide le prostitute convinto di liberare le strade dai peccatori per conto di Dio. Nonostante il numero delle vittime continui ad aumentare, le autorità locali non sembrano aver fretta di risolvere il caso. Guy Nattiv, israeliano, autore di Golda, incentrato sulla figura della prima e unica donna primo ministro di Israele, Golda Meir; con il corto Skin vince nel 2019 l’Oscar: racconto, in un piccolo supermercato di una cittadina di operai, di un uomo di colore che, mentre fa la fila alla cassa sorride a un ragazzino bianco: innocuo episodio che scatena una vera e propria guerra tra gang che si conclude con un contraccolpo scioccante.
Ora Tatami: Leila è una judoka iraniana allenata da Maryam; sogna di vincere la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali di Judo. La Repubblica Islamica dell’Iran però ordina a Leila di fingere di aver subito un infortunio e di ritirarsi dalla gara contro un’atleta israeliana.
Tatami è il luogo dove si incontrano per la prima volta un regista israeliano e una regista iraniana: “Abbiamo unito le forze per raccontare la storia di atlete coraggiose” dicono gli autori. Nattiv e Zar Amir Ebrahimi utilizzano un doppio binario narrativo senza rinunciare agli elementi più spettacolari classici dei film sportivi come il desiderio di vittoria, l’ambizione e la conquista di una medaglia; non solo; si prenda la figura dell’allenatrice: determinata e tuttavia vittima di un crescente conflitto interiore, “figlio” di ricatti alla famiglia, paradigma e atto d’accusa delle pressioni e delle violenze del potere e del regime. Tatami mescola più generi: thriller politico, film di denuncia e venature femministe. Parla della forza e della resistenza delle donne che in tanti regimi totalitari e teocratici sono considerate meno di nulla. Pellicola incisiva, convincente, che dà voce a molte come Leila: capaci di sfidare un potere arrogante e violente per salvare la propria libertà e dignità.